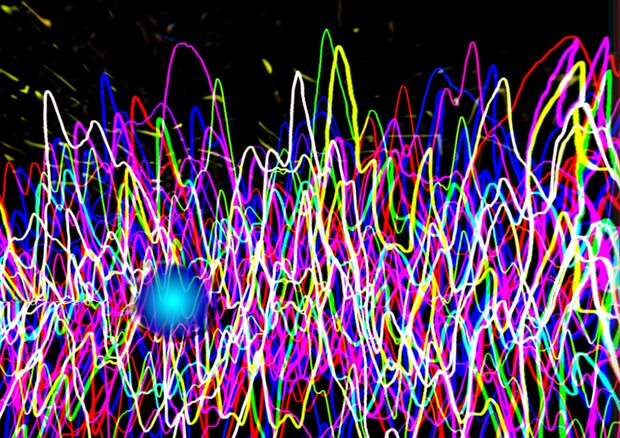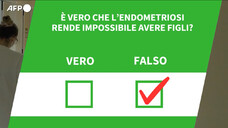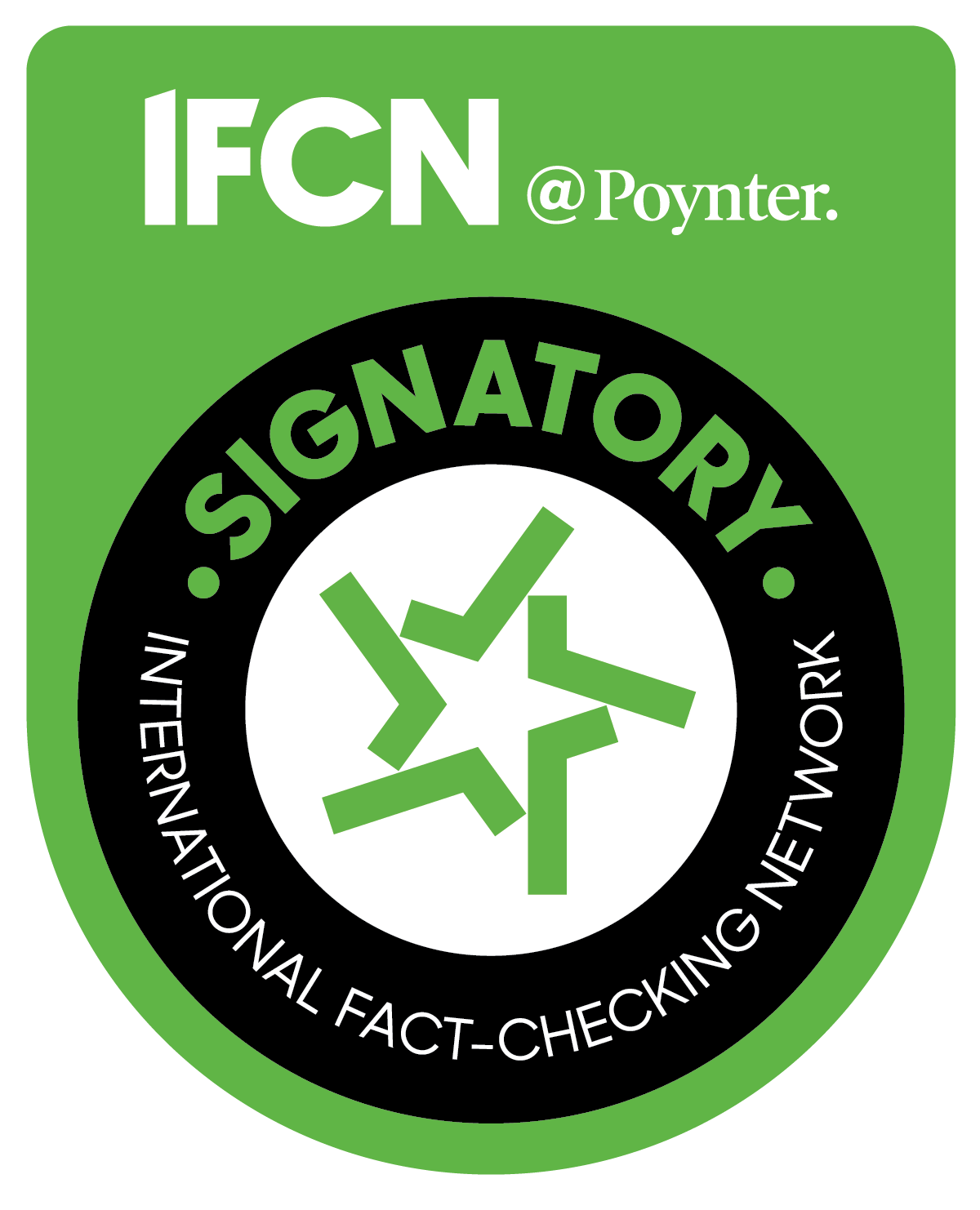Cosa verifichiamo
Con il termine Aldfg (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear) si fa riferimento a tutti quegli attrezzi da pesca che, per molteplici ragioni, finiscono persi o abbandonati in mare, provocando gravi danni all’ambiente. Le cause di queste perdite sono diverse: a volte si tratta di incidenti dovuti a condizioni meteorologiche estreme, mentre in altri casi le reti vengono volontariamente lasciate in acqua per evitare i controlli, ad esempio durante attività di pesca illegale o in zone non autorizzate. Negli ultimi decenni, la quantità e la diffusione di tali attrezzature sono aumentate a causa dell’intensificazione dello sforzo di pesca. Inoltre, il passaggio a materiali sintetici – meno costosi e più resistenti – ha ulteriormente aggravato il loro impatto ambientale. Diventa quindi essenziale comprendere quante attrezzature da pesca vengano perse o abbandonate ogni anno, quali siano gli effetti della cosiddetta “pesca fantasma” sulla biodiversità marina, quali habitat subiscano i danni maggiori, in che misura le Aldfg contribuiscano all’inquinamento da microplastiche e, infine, quali strategie possano essere messe in atto per arginare questo fenomeno.
Analisi
Un dato spesso citato è quello secondo cui 6,4 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nei mari ogni anno; di queste, il 10% proverrebbe da attrezzatura da pesca abbandonata o persa, quindi circa 640.000 tonnellate (Macfadyen et al., 2009) ( Macfadyen), spiega Cecilia Silvestri ricercatrice dell'Ispra. Secondo studi più recenti (Richardson et al., 2019), ogni anno viene perso in mare il 5,7% delle reti da pesca, l’8,6% delle nasse e addirittura il 29% delle lenze. L’entità del fenomeno varia a seconda della categoria di attrezzi e dell’habitat bentonico in cui avviene la dispersione.
In uno studio successivo, Richardson et al. (2022) hanno stimato che, su scala globale, vengano rilasciati ogni anno 2.963 km² di reti da posta, 75.049 km² di reti a circuizione, 218 km² di reti a strascico, 739.583 km di palangari e oltre 25 milioni di nasse e trappole. In Italia, uno studio di Angiolillo et al. (2023) evidenzia che l’86% dei rifiuti marini rinvenuti sui fondali sia riconducibile ad attività di pesca, con una netta prevalenza di lenze, corde e reti abbandonate, perse o dismesse.
Gli impatti di queste reti fantasma sugli ecosistemi marini sono molteplici, indica Silvestri. Innanzitutto, l’abrasione e il soffocamento rappresentano due forme di danno frequenti, l’attrito continuo delle reti sul fondale può provocare perdita di tessuto e indebolimento di coralli e altri organismi sessili, esponendoli maggiormente a infezioni e patogeni (Gesamp, 2021). Inoltre, le reti possono ricoprire intere colonie di coralli e spugne, privandole di luce e ossigeno, con gravi conseguenze fisiologiche. Nel Mediterraneo, Angiolillo e Fortibuni (2020) hanno rilevato che il 41% delle specie impattate appartiene al gruppo degli Cnidari (coralli e gorgonie).
Un secondo grave impatto è l’intrappolamento (entanglement). Le reti fantasma continuano a catturare organismi marini (il cosiddetto ghost-fishing), provocando morte per soffocamento, inedia o impossibilità di nuotare. A livello globale, il 98% degli eventi di entanglement nei cetacei è causato da attrezzature da pesca abbandonate (Baulch & Perry, 2012), il 74% negli squali e nelle razze (Parton et al., 2019). In Italia, Angiolillo et al. (2023) segnalano che l’intrappolamento da reti fantasma colpisce il 22% dei pesci, il 13% di crostacei, quali soprattutto granchi, gamberi e aragoste e l’8% di echinodermi, quali stelle marine e ricci.
La pesca fantasma (ghost-fishing), spiega ancora la ricercatrice dellIspra, tende a ridurre la sua efficienza nel tempo, perché i materiali si degradano o vengono ricoperti da bioconcrezioni che ne limitano la capacità di cattura residua. Tuttavia, il fenomeno può protrarsi a lungo, anche per anni o decenni, in base al tipo di rete e alle condizioni ambientali. Secondo un rapporto Fao (Gilman et al., 2016) sugli attrezzi da posta, il tempo medio massimo stimato per la perdita di efficienza è di circa un anno, con variazioni da 58 giorni fino a 27 mesi. Inoltre, anche le nasse perse continuano a catturare organismi, creando un circolo vizioso, gli animali intrappolati, morendo all’interno, attirano ulteriori prede, con conseguenti catture prolungate nel tempo.
Dal punto di vista dell’inquinamento plastico, la maggior parte delle reti è costituita da materiali sintetici (nylon, polietilene) che si degradano lentamente, rilasciando microplastiche (particelle inferiori a 5 mm) nell’ambiente marino. Una volta disperse, le microplastiche vengono ingerite dagli organismi e si trasferiscono lungo la catena trofica. Diversi studi (Valente et al., 2019; 2022; 2025) indicano che oltre il 65% dei pesci analizzati ingerisce microplastiche.
Le conseguenze economiche per il settore della pesca sono evidenti: le reti fantasma comportano spese di sostituzione degli attrezzi smarriti, nonché la perdita di potenziali catture, che restano intrappolate in modo incontrollato.
Per arginare questo fenomeno, sono in corso diverse iniziative a livello globale e locale, concentrate su recupero, sensibilizzazione e prevenzione. In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede il progetto Marine Ecosystem Restoration (Mer) che, tra gli obiettivi, include la rimozione delle reti fantasma. L’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha avviato un programma di pulizia dei mari in 20 siti costieri italiani, con attività di rimozione, raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo delle reti, in corso fino al 30 giugno 2026.
La Legge Salvamare (L.17 maggio 2022, n. 60), rappresenta un ulteriore passo in avanti, in quanto facilita la gestione dei rifiuti marini – comprese le reti abbandonate – equiparandoli a rifiuti urbani e semplificando così le procedure di smaltimento. La legge, inoltre, promuove campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per contrastare la dispersione di questi materiali in mare.
In tema di prevenzione, il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 404/2011 e le Linee guida della Fao sulla marcatura degli attrezzi da pesca (Fao, 2019) definiscono i criteri sulla marcatura degli attrezzi da pesca ma solo attraverso nuove tecnologie di georeferenziazione delle stesse si potrà contribuire, nel lungo periodo, a ridurre l’impatto delle reti fantasma sugli ecosistemi marini.
Conclusioni
Le ghost nets rappresentano una minaccia tanto subdola quanto devastante per la biodiversità marina. Sebbene non si sappia ancora con precisione quante reti abbandonate infestino i mari né dove siano esattamente distribuite, è chiaro che l’impatto sulle specie e sugli ecosistemi è già enorme. A fronte di questo rischio concreto, gli sforzi di prevenzione e recupero risultano ancora insufficienti e necessitano di maggiore coordinamento e sostegno, sia a livello istituzionale sia da parte di organizzazioni e comunità locali. Tuttavia, l’attenzione politica e l’interesse mediatico verso il problema stanno crescendo, aprendo la strada a iniziative e normative più efficaci. È fondamentale proseguire in questa direzione, intensificando la ricerca e promuovendo azioni concrete per arginare un fenomeno che può essere combattuto solo attraverso un impegno collettivo e a lungo termine.
Fonti
Angiolillo M and Fortibuoni T. (2020). Impacts of Marine Litter on Mediterranean: From Shallow to Deep Waters Front. Mar. Sci., 29 September 2020 Sec. Marine Ecosystem Ecology Volume 7 – 2020.( https://doi.org/10.3389/fmars.2020.581966).
Angiolillo M., Fortibuoni T.,Di Lorenzo B., Tunesi L. (2023) First baseline assessment of seafloor litter on Italian coralligenous assemblages (Mediterranean Sea) in accordance with the European Marine Strategy Framework Directive. Mar Pollut Bul. (doi: 10.1016/j.marpolbul.2023.114597)
Baulch, S. & C. Perry. (2012). A sea of plastic: evaluating the impacts of marine debris on cetaceans. Marine Mammal Commission Report SC/64/ E10. 24 p.
FAO. (2019). Voluntary Guidelines on the Marking of Fishing Gear. Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. Directrices voluntarias sobre el marcado de las artes de pesca.
Rome/Roma. 88 pp. Licence/Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. (https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/65cebd33-16c0-48ef-aded-1ea17b96589d/content)
GESAMP (2021). Sea-based sources of marine litter. IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP/ISA Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, Rep. Stud. GESAMP No. 108, 109 p. (http://www.gesamp.org/site/assets/files/2213/rs108e.pdf)
Macfadyen, G., Huntington, T., & Cappell, R. (2009). Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 523, Rome: FAO. (https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c49669a-bc33-4792-ae8c-b24d985c79ad/content).
Parton, K.J., Galloway T.S. & Godley B. J. (2019). Global review of shark and ray entanglement in anthropogenic marine debris. Endangered Species Research. 39: 173–190. (https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/ESR-39.pdf).
Richardson, K., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2019). Estimates of fishing gear loss rates at a global scale: A literature review and meta-analysis. Fish and Fisheries, 20(6), 1218-1231. (https://doi.org/10.1111/faf.12407).
Richardson K., Hardesty B.D., Vince J., Wilcox C. (2022). Global estimates of fishing gear lost to the ocean each year.Sci. Adv.8,eabq0135.(DOI: 10.1126/sciadv.abq013).
Gilman, E., Chopin, F., Suuronen, P., & Kuemlangan, B. (2016). Abandoned, lost and discarded gillnets and trammel nets: Methods to estimate ghost fishing mortality, and status of regional monitoring and management. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 600, Rome: FAO.(https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/420301ff-2fb2-473c-98f5-a28ff6106861/content).
Valente, T., Sbrana, A., Scacco, U., Jacomini, C., Bianchi, J., Palazzo, L., de Lucia, G.A., Silvestri, C., Matiddi, M. (2019). Exploring microplastic ingestion by three deep-water elasmobranch species: a case study from the Tyrrhenian Sea. Environ. Pollut. 253, 342–350. (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.07.001).
Valente, T., Pelamatti, T., Avio, C.G., Camedda, A., Costantini, M.L., de Lucia, G.A., Jacomini, C., Piermarini, R., Regoli, F., Sbrana, A., Ventura, D., Silvestri, C., Matiddi, M.( 2022). One is not enough: monitoring microplastic ingestion by fish needs a multispecies approach. Mar. Pollut. Bull. 184, 114133. (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114133).
Valente, T., Costantini, M.L., Careddu, G., Berto, D., Piermarini, R., Rampazzo, F., Sbrana, A., Silvestri, C., Ventura, D., Matiddi, M. (2023). Tracing the route: using stable isotope analysis to understand microplastic pathways through the pelagic- neritic food web of the Tyrrhenian Sea. Sci. Total Environ. 885, 163875. (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163875).